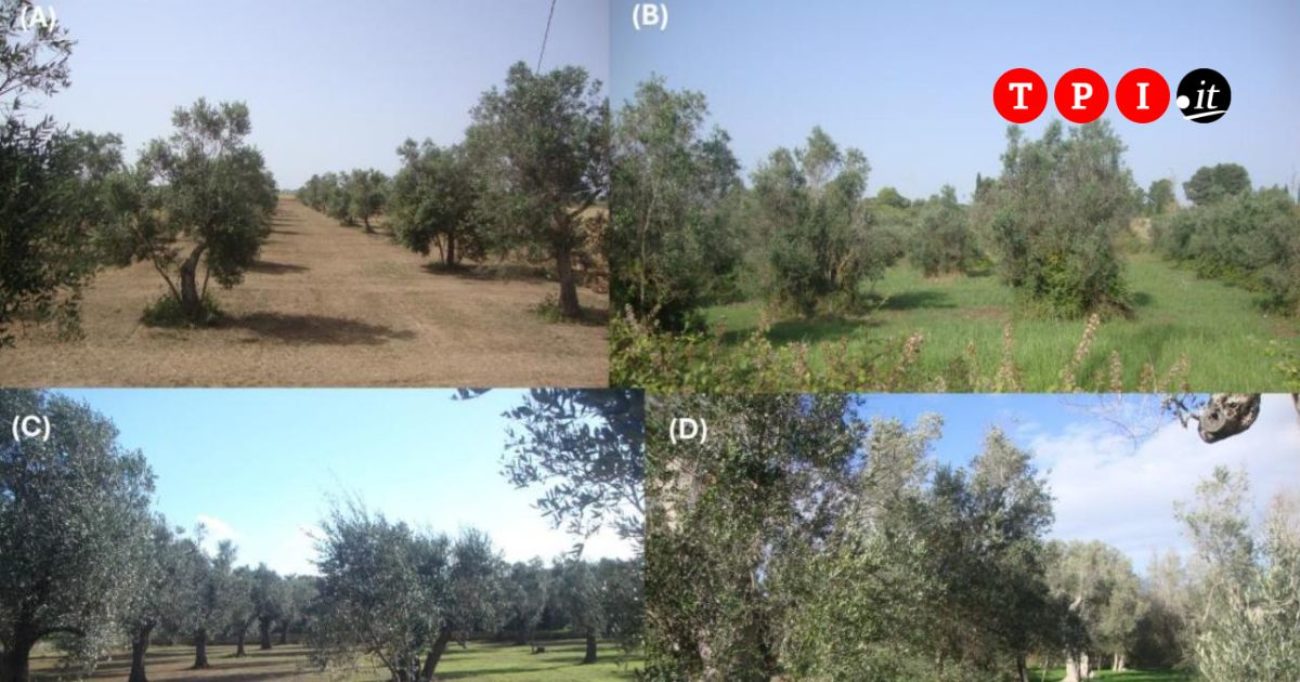L’avvocato Caterina Malavenda si racconta a TPI: “Vivo senza social e sono felice”

"La libertà di stampa? Non è più riconosciuta come un bene da tutelare. Prima le querele erano basate sui fatti. Ora, a volte, servono a intimidire". Il legale di tante battaglie per il diritto di cronaca spiega a TPI come sono cambiati i rapporti di forza tra il potere e l’informazione
Avvocato e giornalista pubblicista, Caterina Malavenda è tra le massime esperte italiane di diritto dell’informazione e della comunicazione. Ha difeso alcune tra le firme più importanti del giornalismo italiano, da Oriana Fallaci a Oliviero Toscani, passando per casi clamorosi che hanno fatto la storia della nostra libertà di stampa. Il suo ultimo volume, “E io ti querelo”, edito da Marsilio (2025), ripercorre dieci processi emblematici che raccontano come la libertà d’espressione sia stata messa alla prova dai tribunali italiani.
Le querele per diffamazione a mezzo stampa sono aumentate rispetto al passato?
«Mi occupo di processi per diffamazione dal 1985 e quando ho iniziato più che il numero, sempre piuttosto elevato, era l’oggetto delle querele ad essere diverso, quasi sempre comprensibile, quindi era raro che avessero una valenza intimidatoria, bastava difendersi. Man mano però le cose sono cambiate al punto che oggi a volte mi capita di esaminarne alcune e di non capire quale sia il problema, anche dopo aver letto l’articolo contestato: ecco quelle sono certamente querele temerarie, fatte solo per dare fastidio».
Non ci sarà anche un problema di egotismo dei giornalisti e di un calo generale della qualità della stampa?
«Una volta l’informazione si focalizzava sui fatti, che il querelante contestava sostenendo che fossero falsi. I ruoli per di più erano definiti, i cronisti si occupavano di quel che accadeva e gli opinionisti lo commentavano, con espressioni anche dure, ma di regola senza scadere in offese gratuite. Oggi, invece, il linguaggio è cambiato, direi involuto e non raramente anche chi dovrebbe fare informazione, a proposito di egotismo, indulge nella critica, cosa del tutto legittima, ma ricorrendo a forme espressive aggressive. Il focus dei processi, perciò, si è spostato sulla incontinenza verbale, diventata il vero cavallo di battaglia di chi querela per diffamazione. Pur riconoscendo che il contenuto dell’articolo è vero, ne contesta la forma scurrile, subdola o insinuante, il che rende il lavoro degli avvocati e dei magistrati molto più complicato. È più semplice accertare se un fatto è vero o falso piuttosto che giudicare se un’opinione abbia superato o meno il labile confine tracciato dal codice penale».
Si punta più a intrattenere che a informare il pubblico?
«Ormai quel che succede, quando finisce sui giornali, persino nelle edizioni online, è già masticato e metabolizzato. Tutti già conoscono i fatti, tanto che non vengono quasi più raccontati, restano sullo sfondo. Per di più, soprattutto le testate più piccole, che hanno bisogno di attirare l’attenzione, assumono posizioni radicali sulla notizia e si contrappongono le une alle altre, in una sorta di ping pong “urlato”. Chi fa querela, perciò, ha gioco facile nel sostenere che è stato superato l’unico limite alla critica, ossia l’aggressione sul piano personale. La critica è sempre legittima, anche se urticante, fastidiosa, petulante persino offensiva, purché contribuisca al dibattito pubblico e non serva solo ad attaccare il criticato. È in questo contesto, che trova terreno fertile il querelante, che può essere tanto un politico che un imprenditore criticati per il loro operato, quanto un personaggio dello spettacolo additato per come parla o per come si veste. Spesso, così facendo, si deborda nell’offesa gratuita sul piano personale, che viene sanzionata».
Una volta Roberto Saviano mi disse che la querela è una medaglia al valore.
«Un tempo credo fosse davvero così, voleva dire che avevi dato fastidio e l’assoluzione, se arrivava, era una gran bella soddisfazione. Oggi è la polarizzazione, che è la negazione stessa dell’informazione per come la conosciamo, a farla da padrone. Una scelta di campo netta va bene sul piano politico, per identificarsi e distinguersi dagli avversari. Nel giornalismo, invece, quando è esasperata può diventare controproducente, anche se mi rendo conto che molti piccoli giornali devono creare una comunità che si identifichi con loro e li compri. Quindi oggi come dicevo sul giornale non si cercano più le notizie, che si trovano nei siti o attingendo alle agenzie di stampa. Sono cambiati così il prodotto e le questioni giudiziarie che ne derivano. Spesso mi trovo a difendere giornalisti per il modo in cui hanno scritto e per non la veridicità del contenuto. La conseguenza è un insieme di sentenze spesso incongruenti, nelle quali lo stesso termine ad esempio è ritenuto di volta in volta lecito o illecito. E siccome mancano parametri obiettivi il giudice, che può farsi guidare anche da convinzioni e affinità personali o anche solo da una forte resistenza all’uso disinvolto delle parole, quando deve stabilire se sia stato superato o meno il confine della critica legittima, può fissare dove vuole l’asticella: basta una parola, un aggettivo, un’insinuazione per condannare. Non esiste un criterio univoco, quindi tutto dipende dalla sua valutazione inevitabilmente soggettiva».
Esistono esempi di giornalismo virtuosi che il potere teme?
«Il giornalismo d’inchiesta è l’unico ancora in grado di dar fastidio a chi lo detiene. Il cronista che riesce, attraverso le sue fonti, a tirar fuori e a rendere pubbliche vicende rimaste nell’ombra, a fare uno scoop, diventa un caso che attira attenzione e suscita riprovazione. E siccome scatena le reazioni più forti, andrebbe difeso senza se e senza ma. Il potere fa tutto quello che può per tacitarlo o screditarlo. Poi quando la parola passa alla magistratura cozzano fra loro due esigenze diverse. Alla necessità del giornalista di proteggere le fonti si oppone il dovere del magistrato di risalire alla verità e, dunque, di scoprirle, sentirle e, se del caso, di incriminarle per concorso nella diffamazione. Dunque, l’obiettivo è identificarle, avvalendosi di intercettazioni, sequestri di telefoni, tablet, computer e altri dispositivi. Così però il rischio è che, per paura, nessuno parli più con i giornalisti. Faccio un esempio: una delle modalità più semplici per condurre un’inchiesta è riprendere di nascosto con una telecamera, montare il servizio e mandarlo in onda, oscurando il volto di chi ha detto cose scomode. Sempre più spesso le Procure chiedono copia del girato grezzo, in cui le fonti sono a volto scoperto. La magistratura fa il suo mestiere ma questo impatta in maniera devastante su quello del giornalista, perché consegnare il girato grezzo significa mettere in mano alla Procura e al querelante, quindi al potere, le fonti del servizio, che si sono fidate. Il giornalismo d’inchiesta quindi rischia di morire, se non si fa davvero muro, bisognerebbe essere disposti anche a farsi arrestare, se necessario».
Si dice che Andreotti non abbia mai presentato querela. Cos’è cambiato nel rapporto tra potere e stampa?
«La caratura politica di una personalità dipende dalle sue azioni. Chi è autorevole e si muove ad altissimi livelli non ha bisogno di fare querele. Lascia correre perché niente può scalfirne davvero l’immagine. Su Andreotti sono state scritte cose terribili, ma si mostrava superiore e andava avanti per la sua strada. Chi si sente sicuro nel suo ruolo, penso ad Andreotti, ma anche a Spadolini, Craxi e Forlani non ha bisogno di querelare. Loro non si sono mai offesi, consideravano le vignette terribili, che venivano loro dedicate, il prezzo da pagare per il potere che avevano. Forse ora si è perso un po’ il senso dell’umorismo, l’autorevolezza è andata scemando e manca anche lo spirito per apprezzare la satira. La paura è che queste forme espressive possano in qualche modo diminuire il prestigio, ma questo succede solo a chi non è abbastanza solido da reggerle».
Oggi la libertà di stampa è più fragile?
«Non è più riconosciuta come una libertà da tutelare. Oggi impera la cultura del “free speech”, ossia l’idea che si possa dir tutto di tutti, dovunque. Questo criterio, però, poi, come abbiamo visto dopo l’assassinio di Charlie Kirk negli Usa, è spesso a senso unico: vale per me ma non per il mio avversario. È uno “speech” non proprio “free”. D’altro canto troppa libertà dà fastidio, quindi si comincia a dire che va bene il diritto di parola ma a piccole dosi e non sempre. A queste difficoltà, si aggiunge il degrado progressivo che genera conseguenze difficilmente fronteggiabili. Una volta la libertà di stampa era tutelata anche dalla presenza di giornalisti autorevoli, giudici capaci nel loro lavoro e querelanti di un certo livello. Il processo era veramente uno scontro di idee. Man mano che si deteriora il linguaggio, nei processi occorre occuparsi di insulti, espressioni molto forti e i contenuti perdono di importanza. I giornalisti in particolare, come categoria non godono più dello stesso prestigio quindi, se pur degni di essere rispettati, tutelati e difesi, sono diventati degli imputati qualunque. I magistrati stessi, di fronte a temi così poco stimolanti, ritengono questi processi una perdita di tempo. Gli unici a cui interessano davvero sono il querelante e il querelato. Diventa quasi un fastidio, con uno che grida per avere giustizia e l’altro che si professa innocente, come in qualsiasi altro processo. Così la libertà di stampa non è più sentita come qualcosa da difendere davvero, anche perché l’informazione interessa sempre meno».
E perché?
«La mattina ascolto in tv le notizie di giornata e inevitabilmente i primi dieci minuti sono dedicati a Gaza e all’Ucraina, poi cinque minuti a Trump e alla fine, forse, qualche minuto a qualcosa che ci interessa direttamente. L’ascoltatore medio spesso non presta attenzione ad argomenti che a torto gli sembrano lontani ed estranei. Poi ciascuno è convinto di potersi informare autonomamente andando in rete. Chi vuol sapere di me si collega e legge cosa ne hanno scritto altri, di cui spesso non si sa nulla: chi sono, che fanno, quanto siano davvero informati e quanto vogliano davvero informare, per non parlare delle notizie che ci arrivano sul telefonino senza essere richieste. Questo genere di “informazione” raffazzonata è scambiato per verità e quella tradizionale interessa sempre meno perché le persone ritengono di poter fare da sole. In questo contesto il giornalista diventa uno qualunque, di cui si può fare a meno. Questo crea un disinteresse di fondo da parte dell’opinione pubblica, che è il vero problema dell’informazione attuale. Non aiuta, di certo, il continuo parlarsi addosso della categoria e il fatto che ogni giornalista che lavora per una testata abbia anche i suoi profili social in cui si sente libero di dire quel che vuole a scapito della sua immagine professionale».
Qual è la soluzione?
«Il giornalismo, come l’abbiamo conosciuto, non esiste più da tempo. Continuiamo a difenderlo ma la deriva ormai è inarrestabile, con la rete che avanza e lo fagocita».
Il web andrebbe regolamentato?
«È impossibile, è come prendere il vento con le mani. Non si può regolamentare qualcosa che va oltre i confini nazionali e quando è quasi impossibile identificare il responsabile».
Cosa si può fare?
«Educare a un approccio corretto a Internet».
Come?
«Una volta si insegnava a leggere i giornali, oggi dobbiamo insegnare a chi vive in rete a usare questo strumento in maniera appropriata, perché raggiunga il suo scopo, che è quello di far circolare le informazioni e le opinioni».
Come la mettiamo con gli oligopolisti del web che controllano i mezzi di produzione, i brevetti e gli algoritmi?
«Da me non ricavano neppure un euro, grazie alla mia ricetta».
Quale?
«Non ho profili social, né un sito web, non uso la rete, né comunico attraverso il web. Ho solo una casella di posta elettronica e una pec, bastano e avanzano, così ho il tempo di leggere giornali e libri e di ascoltare la radio che adoro».
Vive fuori dal mondo.
«Vivo come voglio e mi basta. È la mia ricetta personale e mi fa vivere tranquilla. Mi rendo conto che, nel mondo globalizzato, è una scelta impossibile da attuare e che ormai non si possa più prescindere da questi strumenti. Ma io ormai ho 70 anni, ho un’altra testa. Chi li usa deve adeguarsi e accettare il prezzo da pagare. Spesso mi dicono: “Mi stanno crocifiggendo sui social cosa posso fare?”. Allora rispondo: “Pazienza, un paio di giorni e poi passa”. E alla fine passa davvero, perché l’attenzione devia su altro».
Ma chi detiene davvero il potere in Italia?
«I potentati economici e finanziari, non c’è dubbio».
Quindi chi?
«Guardiamo i mercati: non fanno una piega nonostante tutto quello che succede nel mondo. Vanno per la loro strada. Il potere economico e finanziario è sempre nell’ombra, nascosto, e muove le fila. Non a caso è il meno aggredito, perché meno visibile, e quando lo tocchi, ti fai male».
Cosa deve accadere perché il giornalismo torni a essere un vero potere?
«Che torni di nuovo ad essere i giornalismo. I pochi che si distinguono davvero, mi vengono in mente Ranucci, Gabanelli, Travaglio, (Thomas) Mackinson, uno bravissimo che fa il suo mestiere con le fonti alla vecchia maniera, per citarne solo alcuni, hanno il loro seguito. Se i giornalisti tornano a fare quello che ci si aspetta che facciano, allora il giornalismo può riprendersi».
È un problema di editori?
«Insegno in master di giornalismo in varie università e ogni anno incontro un centinaio di ragazzi che vogliono fare questo mestiere, pagando – e non poco – per seguire i corsi. Questo vuol dire che in fondo i giovano credono ancora in questo mestiere, è un fenomeno che mi sorprende ogni anno. Dall’altra parte ci sono gli editori, ossia imprenditori che vogliono fare profitti. E’ loro interesse che i giornali vendano, quindi che la qualità sia accettabile. Non vogliono spendere soldi per cause insidiose e quindi hanno un interesse confliggente con quello di chi invece vuole occuparsi di temi che diano fastidio, ma se lo fanno nel modo giusto, l’editore paga più volentieri, specie quando si vincono le cause».
Quindi?
«Bisognerebbe riqualificare i giornalisti agli occhi di chi non fa questo mestiere. Ci sono molte eccellenze fra loro, le incontro tutti i giorni per lavoro. Se le motivi, forse in forme diverse da quelle che conosciamo e con un approccio differente all’utente, è possibile che l’informazione riprenda quota. C’è voglia di sapere e soprattutto di raccontare. Come si spiegherebbero altrimenti tutte queste associazioni internazionali di giornalisti investigativi? Evidentemente non trovano spazio altrove. Spesso scrivono online sotto pseudonimo, mentre firmano con il proprio nome sui loro giornali. Bisogna incentivare la domanda, incuriosendo il pubblico».
Tornando alle querele, non sarebbe il caso, oltre alla condanna al pagamento delle spese legali, di imporre un risarcimento a chi ha subito una querela temeraria?
«La legge riconosce già il risarcimento a chi ha subìto ingiustamente un processo penale a causa di una querela temeraria, ma solo se viene assolto perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso. Il giornalista però viene assolto di solito perché il fatto, cioè la diffamazione, non costituisce reato, perché ha solo esercitato il diritto di cronaca e questa formula non consente alcun risarcimento. Basterebbe aggiungerla alle altre due».
Quindi si può fare una riforma che limiti gli abusi.
«Certo, integrando la norma in Parlamento, ma i politici non hanno alcun interesse a farlo perché altrimenti sarebbero chiamati a pagare in prima persona per querele temerarie, cui non sono ostili. Lo sanno, è stato chiesto tante volte. Io stessa l’ho fatto, nel corso delle mie due audizioni in Parlamento, ma non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire».