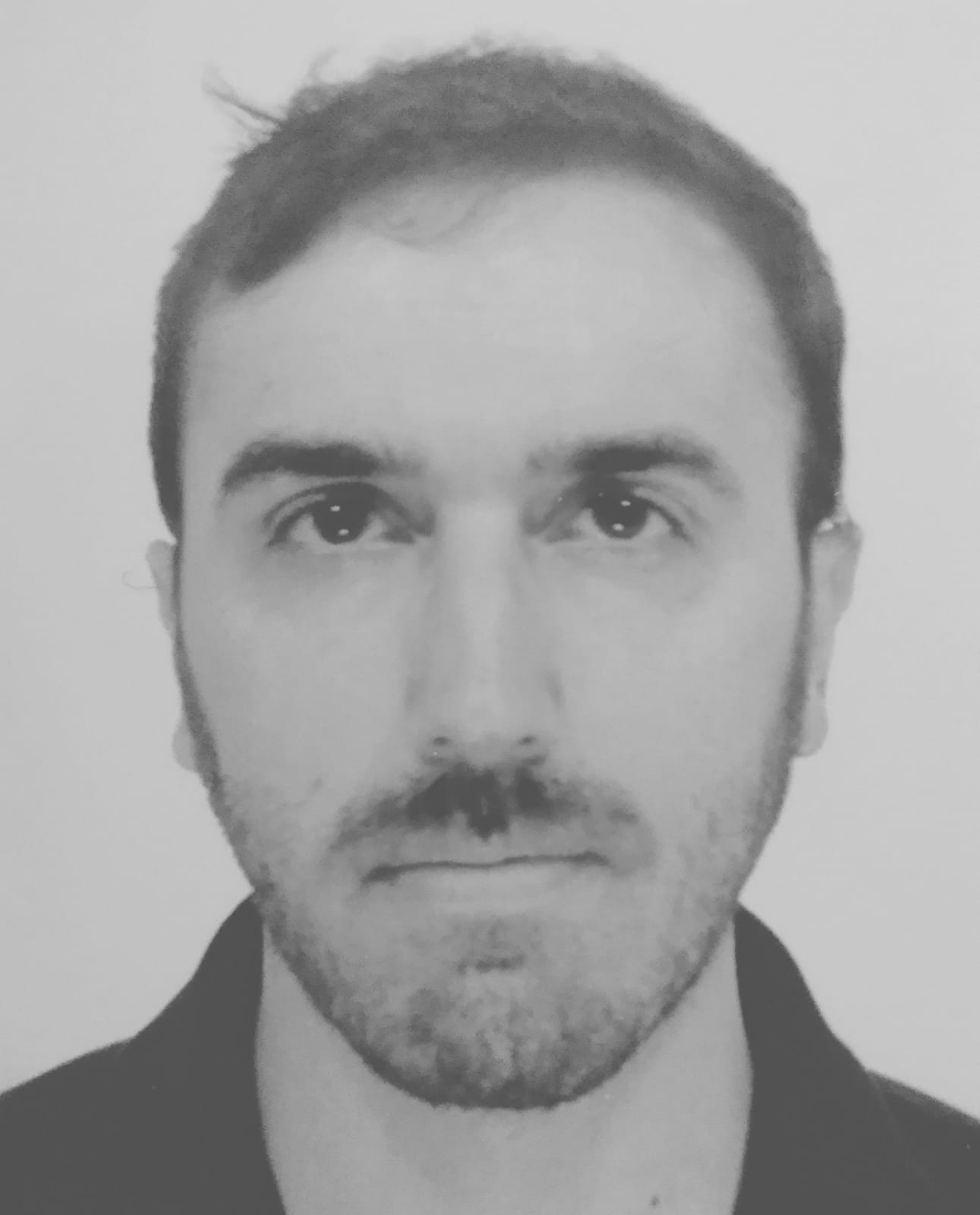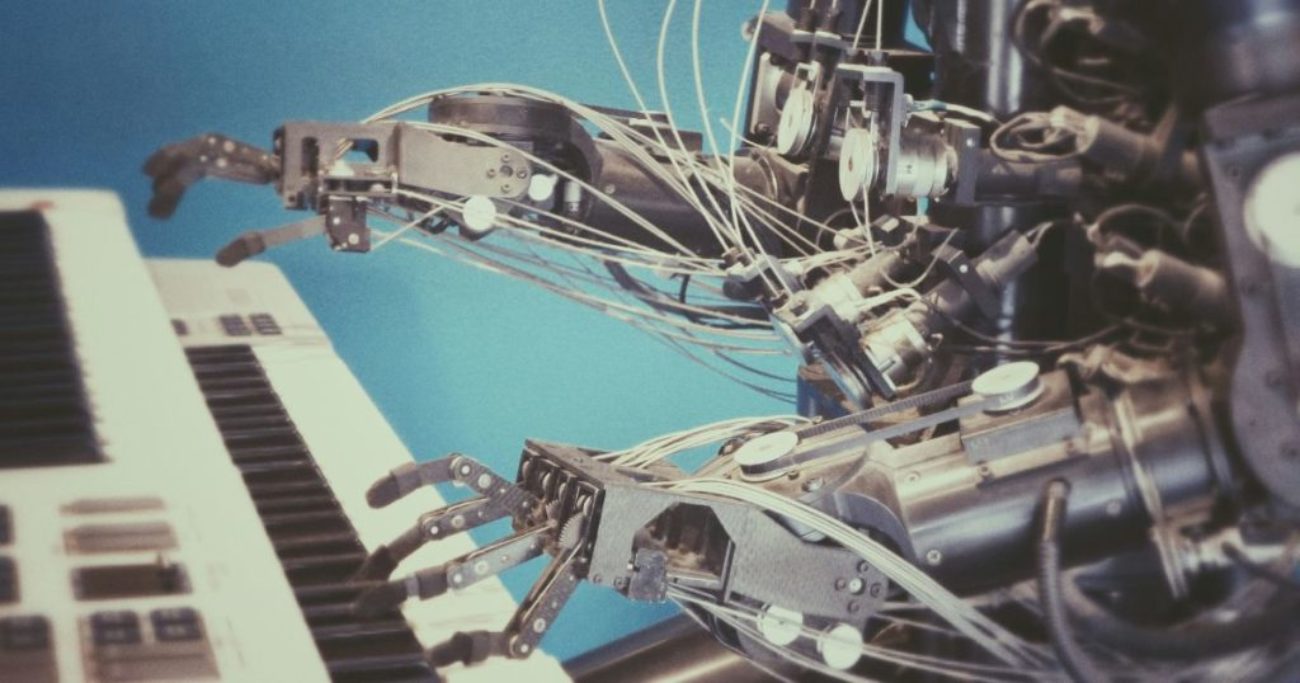Il regime venezuelano di Donald: cosa vuole fare Trump col petrolio di Caracas

Gli Usa hanno catturato Maduro, ma la dittatura di Caracas sopravvive. Il leader della Casa Bianca punta a scacciare dal Paese le presenze cinesi, russe e iraniane e a mettere le mani sull'oro nero. Prima però deve convincere le Big Oil statunitensi a fare quel che vuole lui
«Questo è il nostro emisfero», ha rivendicato Marco Rubio, segretario di Stato degli Usa, poche ore dopo l’operazione militare statunitense che, il 3 gennaio scorso, ha portato alla destituzione e all’arresto del presidente venezuelano Nicolás Maduro. Lo slogan di Rubio è stato rilanciato anche dalle pagine social ufficiali del Dipartimento di Stato di Washington. Parole che dicono molto dell’approccio sprezzante dell’attuale Amministrazione yankee non solo al diritto internazionale, ma anche alla grammatica delle istituzioni.
Nella sua brutalità, il messaggio se non altro va dritto al punto. Lo ha divulgato anche il presidente Donald Trump, che – messo da parte il debole pretesto della lotta al narcotraffico – ha giustificato il blitz a Caracas con l’applicazione di quella che lui stesso ha definito la «Dottrina Donroe», rivisitazione in salsa donaldiana della Dottrina Monroe, forgiata nell’Ottocento dal presidente James Monroe: il principio guida è che nell’emisfero occidentale (vale a dire il continente americano) comandano solo gli Stati Uniti e non ci può essere alcuno spazio per le altre superpotenze.
Nello specifico dell’operazione “Absolute Resolve” e di ciò che ne dovrebbe seguire, l’obiettivo della Casa Bianca è scacciare dal Venezuela le installazioni civili e militari di Cina, Russia e Iran e mettere le mani sugli abbondanti giacimenti locali di petrolio e di minerali.
Ciò che è meno chiaro è se questa strategia darà i frutti sperati e, soprattutto, quali scenari politici e sociali si aprono adesso per il Paese latinoamericano, dove si stima che circa il 68% della popolazione viva in condizioni di povertà estrema.
Cambio della guardia
Chi sperava che con la caduta di Maduro salisse al potere un esponente dell’opposizione è rimasto deluso. Trump ha glissato sul sostegno alla dissidente liberale María Corina Machado, che, in visita alla Casa Bianca, gli ha consegnato simbolicamente il Nobel per la Pace ricevuto pochi mesi fa (premio al quale ambiva anche lo stesso tycoon). Né il governo è passato nelle mani di Edmundo González Urrutia, che Washington aveva riconosciuto come vincitore delle contestate elezioni del 2024.
Anche dopo l’intervento militare degli Usa, il Venezuela rimane una repubblica bolivariana. Washington ha convalidato l’insediamento alla presidenza ad interim della ex vice di Maduro, Delcy Rodríguez, 56 anni, figlia di un leader marxista morto a 34 anni sotto le torture dell’intelligence che lo riteneva coinvolto nel rapimento per scopi politici di un uomo d’affari statunitense. «La rivoluzione è la nostra vendetta», affermò la donna in un’intervista nel 2018.
Perché la Casa Bianca ha scelto lei, una chávista della prima ora, anziché Machado o Urrutia? La risposta è abbastanza semplice: è stata «preferita la stabilità alla democrazia», come spiegato alla Bbc Charles Shapiro, ambasciatore di George W. Bush a Caracas dal 2002 al 2004
Avvocata di formazione, Rodríguez ha iniziato la sua ascesa politica ai tempi di Hugo Chávez. Negli ultimi dieci anni ha ricoperto le cariche di ministra degli Esteri, delle Finanze e infine del Petrolio, ruolo quest’ultimo che ha potenziato forse le sue credenziali agli occhi della Stati Uniti.
«È essenzialmente disposta a fare ciò che riteniamo necessario per rendere il Venezuela di nuovo grande», ha detto di lei Trump. Il presidente è sicuro di poter manovrare la nuova leader al punto che sui social si è auto-definito lui stesso «presidente ad interim» del Venezuela. Gli Usa, ha poi chiarito in sede ufficiale, «supervisioneranno» il governo di Caracas finché non potranno «effettuare una transizione sicura, adeguata e giudiziosa». Quanto tempo ci vorrà? «Potrebbe durare anni», ha risposto Trump, che ha già escluso la possibilità di tenere elezioni nel breve periodo.
Risarcimenti
Il segretario di Stato Rubio ha presentato un piano in tre fasi – stabilizzazione, ripresa, transizione – in cui centrale sarà la leva petrolifera.
Per iniziare, è previsto che il Venezuela conferisca agli Stati Uniti una quantità compresa tra i 30 e i 50 milioni di barili del suo greggio, pari a un valore che oscilla tra gli 1,8 e i 3 miliardi di dollari. Ma la segretaria all’Energia Chris Wright si è spinta più in avanti, affermando esplicitamente che l’obiettivo è controllare le vendite del petrolio venezuelano «a tempo indeterminato»: il nuovo protocollo imposto da Washington – già operativo – prevede che il denaro ricavato dalla commercializzazione dell’oro nero venga depositato su conti bancari intestati al Tesoro Usa e utilizzato per finanziare lo sviluppo del Paese produttore.
Negli ultimi vent’anni il Venezuela ha venduto il proprio petrolio a prezzi scontati principalmente a Cina e Russia. Ora quegli scambi dovranno cessare. «Faremo scendere i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno», ha dichiarato Trump.
Il presidente, però, deve fare i conti anche con le grandi compagnie petrolifere a stelle e strisce, che vantano risarcimenti miliardari nei confronti del governo di Caracas per le espropriazioni imposte una ventina d’anni fa da Chávez (tra le aziende creditrici ci sono anche l’italiana Eni e la spagnola Repsol, per complessivi 6 miliardi di dollari).
Dopo il raid contro Maduro, Trump ha spiegato di voler coinvolgere le Big Oil nella ricostruzione della disastrata industria petrolifera venezuelana. Il Paese vanta le maggiori riserve del mondo, pari ufficialmente a oltre 300 miliardi di barili (secondo report indipendenti, sono in realtà circa un terzo), ma due decenni di sanzioni statunitensi – sommate a investimenti insufficienti, corruzione endemica e fuga di cervelli – hanno ridotto la filiera nazionale a un pessimo stato. La compagnia petrolifera statale, Pdvsa, è sostanzialmente in bancarotta. La produzione è crollata dai circa 2,5 milioni di barili al giorno del 2010 al livello attuale di un milione.
Per rimettere in piedi il settore servirebbero investimenti per oltre 100 miliardi di dollari, il doppio di quanto le principali aziende statunitensi dell’oil & gas hanno investito complessivamente in tutto il mondo nel 2024. Trump ha invitato le compagnie a farsene carico in cambio delle licenze estrattive. Tuttavia le multinazionali hanno risposto in modo tiepido. Il regime di Caracas, ha ricordato Darren Woods, amministratore delegato di ExxonMobil, «ci ha sequestrato i beni due volte: rientrare una terza volta richiederebbe cambiamenti piuttosto significativi». «Se consideriamo le strutture e i quadri giuridici e commerciali in vigore oggi in Venezuela – ha aggiunto – ci rendiamo conto che non è un Paese su cui investire».
Pochi giorni dopo queste parole di chiusura, la presidente ad interim Rodríguez ha annunciato una proposta per riformare la legge sugli idrocarburi al fine di facilitare gli investimenti. Una mossa che sembra tentare di andare incontro proprio alle istanze delle Big Oil.
Intanto, però, Trump – che rimprovera a Exxon di «giocare troppo a nascondino», minacciando di tagliarla fuori dal nuovo business sudamericano – ha vergato un ordine esecutivo che vieta ai tribunali statunitensi di sequestrare i proventi che l’Amministrazione Usa ricava dal petrolio venezuelano. In questo modo, le aziende petrolifere creditrici di Caracas non potranno rifarsi su tali somme.
Il mercato e lo Stato
«La visione che sta alla base dell’ordine esecutivo di Trump è che il mercato viene dopo gli interessi nazionali», spiega a TPI Francesco Sassi, assistant professor di Geopolitica dell’energia all’Università di Oslo. «Le compagnie petrolifere non ne saranno felici, ma l’Amministrazione Usa vuole imporre un controllo molto più stretto sulla governance delle politiche energetiche del Paese».
«Per la Casa Bianca – continua l’esperto – il greggio venezuelano non è soltanto l’obiettivo, ma anche uno strumento: il piano è utilizzare i proventi del petrolio per stabilizzare il regime chávista. Gli Stati Uniti vogliono controllare quanto, come e a chi il greggio venezuelano viene venduto. Ma non è detto che ci riusciranno, perché le infrastrutture energetiche del Paese sono obsolete e perché le grandi aziende statunitensi del settore, che devono rendicontare le proprie scelte strategiche a diversi investitori, tra cui gli hedge fund, sono riluttanti a investire in un’area a forte instabilità politica. Come minimo, sarà un percorso lungo».
«Quel che è certo – sottolinea Sassi – è che Trump ha lanciato un segnale fortissimo a tutti i produttori di petrolio dell’Opec+ e alla Cina, che negli ultimi due decenni ha investito molto in America Latina. Il messaggio è, da un lato, che nell’emisfero occidentale contano solo gli interessi di Washington e, dall’altro, che per gli Stati Uniti, che non hanno mai prodotto così tanto petrolio e così tanto gas, la politica energetica e la politica estera sono ormai fuse. Un cambiamento di cui anche l’Europa, in larga parte dipendente dalle forniture statunitensi, farebbe bene a tenere conto».
Cacciare gli avversari
L’industria petrolifera venezuelana è stata usata «per arricchire tutti i nostri avversari nel mondo», ha osservato Rubio. La Casa Bianca punta dunque a utilizzare la leva energetica – il petrolio – per allontanare dal Paese le potenze rivali degli Usa.
Nel mirino ci sono in particolare Cina e Russia. Pechino ha investito grandi somme nel Paese, entrando nella gestione di importanti giacimenti, mentre Mosca è presente con la joint venture tra Pdvsa e Roszarubezhneft. Il settore petrolifero locale ha rapporti costanti anche con l’Iran, che vende al Venezuela la nafta necessaria a diluire il pesante greggio sudamericano.
Ma le relazioni internazionali tra la Repubblica bolivariana e gli avversari degli Stati Uniti non si limitano agli idrocarburi.
La Cina, ad esempio, esercita il controllo di fatto sui preziosi siti minerari del Paese, un tesoro – sfruttato finora solo in minima parte – nel quale spiccano abbondanti riserve di oro, nichel, bauxite, cassiterite e coltan, quest’ultimo ribattezzato da Chávez «oro blu» per i suoi utilizzi nella produzione di sistemi elettronici avanzati, anche militari.
Sul fronte dei minerali essenziali all’industria e alla sicurezza nazionale, gli Stati Uniti sono in larga misura dipendenti dalle importazioni. Ecco allora che in Venezuela sembrano decisi a sfidare la Cina in quella che il britannico The Guardian ha definito «rivalità estrattivista» tra le due superpotenze mondiali.
Non solo. A partire dal 2023 le istituzioni finanziarie del Dragone, principalmente la China Development Bank, hanno prestato circa 60 miliardi di dollari al regime di Maduro. Il rimborso di quei debiti dovrebbe avvenire anche sotto forma di petrolio, ma adesso, con l’irruzione sul campo degli Usa, potrebbe complicarsi.
Quanto alla Russia, lo scorso maggio, il leader del Cremlino Vladimir Putin ha firmato con Maduro un accordo di partenariato strategico che rafforza la cooperazione bilaterale su «energia, estrazione mineraria, trasporti e comunicazioni, nonché sicurezza, antiterrorismo e contrasto all’estremismo».
Mosca da anni è di gran lunga il principale fornitore militare del regime chávista, a cui ha venduto armamenti di ogni tipo, da sistemi di difesa aerea a veicoli corazzati, da armi leggere ai caccia Sukhoi Su-30. Inoltre, secondo l’intelligence ucraina, in Venezuela – dislocati tra Caracas, Maracaibo, La Guaira e l’isola di Aves – ci sono oltre 120 soldati russi, la cosiddetta Task Force Equator, che, sotto il comando del generale Oleg Makarevich, addestrano le forze armate locali.
Nel Paese latinoamericano si segnala l’importante presenza militare anche dell’Iran. Lo scorso dicembre Rubio ha confermato l’esistenza documentata di basi locali della Forza Quds, braccio esterno delle Guardie della Rivoluzione, e della milizia libanese Hezbollah, sostenuta da Teheran. Tra l’Iran e il Venezuela – entrambi membri fondatori dell’Opec – si registrano ingenti traffici di armi. Dal 2006 gli ayatollah forniscono al regime sudamericano droni della serie Mohajer: in Venezuela sono state dislocate anche fabbriche per l’assemblaggio di questi velivoli da combattimento con capacità di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Inoltre, Washington accusa Caracas di fornire alla Repubblica islamica sostanze chimiche utilizzate per i missili balistici.
Catturato Maduro, gli Stati Uniti di Trump ora vogliono “bonificare” il Venezuela rispetto a queste relazioni internazionali. Come si legge nel documento sulla Strategia per la sicurezza nazionale, Washington intende adoperarsi per «negare ai concorrenti non emisferici la possibilità di posizionare forze o altre capacità minacciose, o di possedere o controllare risorse strategicamente vitali, nell’emisfero occidentale».
«La fine dell’inizio»
Se da un lato punta a sovvertire la rete di alleanze del Venezuela e a gestire le sue risorse naturali, dall’altro l’operazione trumpiana non ha mostrato fin qui lo stesso piglio nel voler aumentare il tasso di libertà dei cittadini venezuelani.
È vero che, nei giorni successivi alla cattura di Maduro, la presidente ad interim Rodríguez ha accordato il rilascio di centinaia di detenuti (tra cui gli italiani Alberto Trentini, Mario Burlò, Luigi Gasperin e Biagio Pileri). Il Venezuela «si apre a un nuovo momento politico che permette la divergenza e le differenze ideologiche», ha rassicurato la presidente.
Tuttavia il nuovo governo ha decretato uno stato di emergenza di novanta giorni che attribuisce poteri speciali alle forze di sicurezza. Gruppi paramilitari noti come “colectivos” pattugliano le strade di Caracas e gestiscono posti di blocco per interrogare le persone e ispezionare i loro telefoni. Figure filo-regime continuano a dirigere ministeri, parlamenti statali, municipi e comandi di polizia. Inoltre, ai giornalisti stranieri continua a essere impedito l’ingresso nel Paese.
«La situazione odierna è quasi indistinguibile (da quella precedente, ndr). Era una dittatura ostile e ora è amichevole», ha commentato, parlando con The Guardian, Benjamin Gedan, direttore del Programma per l’America Latina presso lo Stimson Center di Washington ed ex capo del Consiglio per la sicurezza nazionale per il Sud America.
Diversi commentatori internazionali in queste settimane hanno fatto notare che rimuovere il dittatore di turno non basta a porre fine a una dittatura. Soprattutto se – come è il caso del Venezuela – il regime non è un monolite ma un insieme di centri di potere coagulati tra loro per reciproco interesse. Come ha scritto Foreign Affairs, «questo non è l’inizio della fine della lunga lotta di Washington con il Venezuela. Segna la fine dell’inizio e l’inizio di una fase molto più difficile e pericolosa».