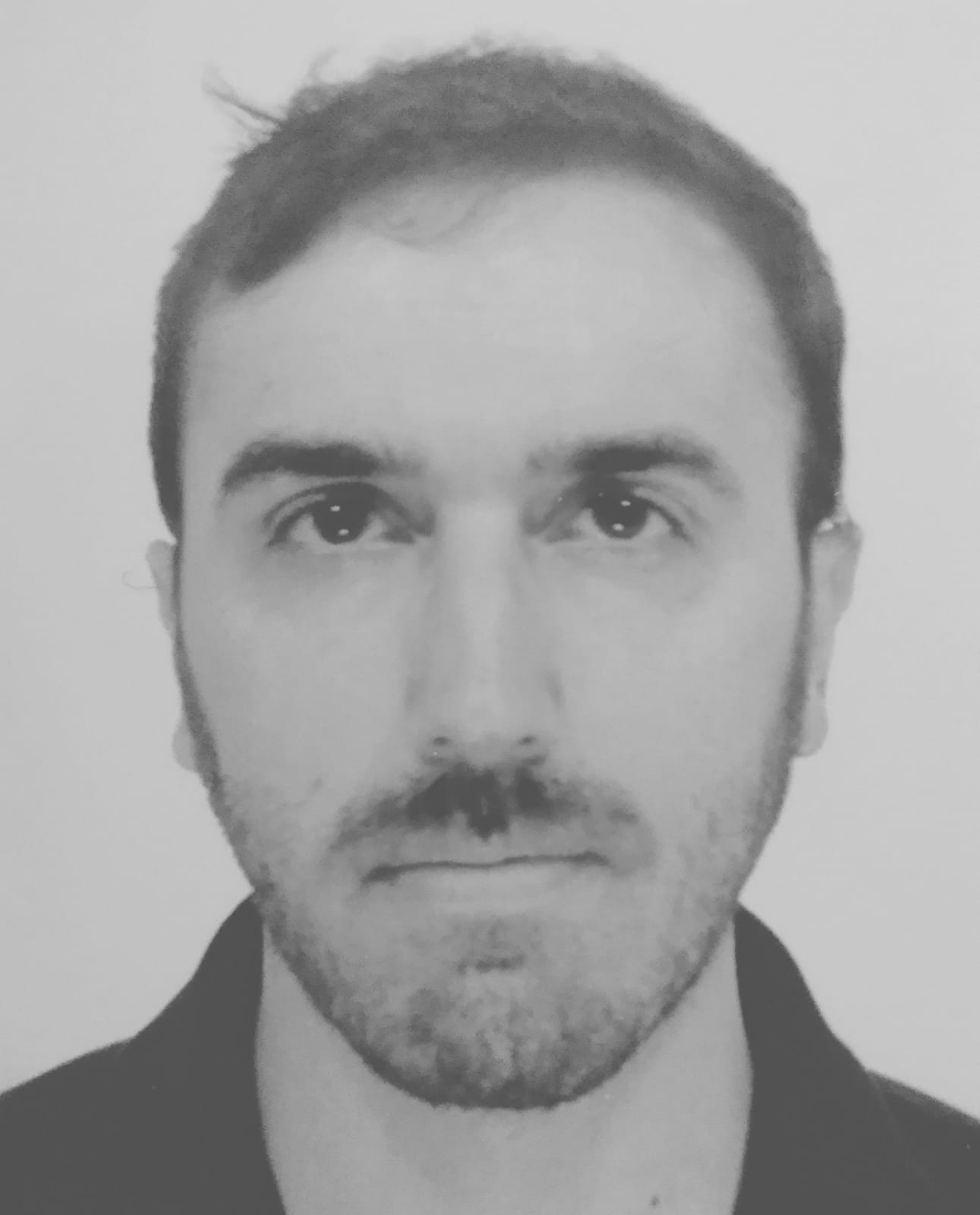Perché la Cina taglia gli investimenti in Europa (dove l’industria continua a dipendere dal Dragone)

Il dominio cinese su auto elettriche e materie prime critiche pone la manifattura del vecchio continente in una posizione di debolezza. L’Ue sta provando a costruire filiere autonome. Ma ci vorrà tempo. Intanto Pechino riduce gli investimenti a casa nostra: in parte per scelte propria, in parte perché spinta via da Bruxelles
Il prossimo 10 dicembre la Commissione europea annuncerà una serie di proposte mirate a risollevare l’industria europea, impantanata in uno dei momenti più difficili dal secondo dopoguerra. L’attenzione generale è rivolta principalmente alla possibile revisione del divieto di vendere autoveicoli nuovi a combustione interna nel territorio dell’Ue a partire dal 2035. Ma il pacchetto dovrebbe includere anche un’altra misura di rilevanza cruciale: secondo un’anticipazione del Financial Times, Bruxelles inasprirà le sue norme sugli investimenti esteri, imponendo a chi vuole aprire una fabbrica nel vecchio continente di assumere lavoratori europei e, almeno in certi settori, di trasferire qui anche il proprio know-how tecnologico.
I destinatari impliciti del giro di vite sono le aziende cinesi, che negli ultimi anni hanno avviato o programmato di avviare diversi stabilimenti produttivi in Paesi membri dell’Ue, specialmente nel settore delle batterie per veicoli elettrici, e tuttavia in molti casi hanno deciso di importare dalla Cina una quota consistente di addetti, componenti e materie prime.
Questo modus operandi ha fatto sì che il valore aggiunto creato in loco sia stato minimo, per non dire nullo. Difatti, la Repubblica Popolare continua a dominare indisturbata nella filiera industriale delle auto elettriche e l’Europa continua a dipendere dalle sue forniture (la Cina genera da sola l’83% della produzione mondiale di batterie).
L’obiettivo della Commissione, adesso, è «garantire che gli investimenti esteri non siano destinati solo a componenti assemblati all’estero», ma contribuiscano al «funzionamento dell’intera catena del valore europea», ha dichiarato al Ft il francese Stéphane Séjourné, commissario alla Strategia industriale.
Dietrofront
Per anni i cinesi hanno investito in Europa quasi esclusivamente sotto forma di acquisizioni societarie o fusioni. A partire dalla fine degli anni Dieci del Duemila, tuttavia, complici regole più restrittive sulla circolazione dei capitali sia in Cina sia nell’Ue, quel tipo di operazioni sono andate costantemente calando: il valore degli investimenti cinesi annui nell’area “Ue più Regno Unito” è così precipitato dai 50 miliardi di euro del 2016 ai 7 miliardi del 2023.
A parzialissima compensazione di questo crollo, le aziende del Dragone, soprattutto dopo la pandemia di Covid-19, hanno intensificato esponenzialmente sul fronte europeo i cosiddetti “investimenti greenfield”, espressione con cui si indica l’avvio da zero di nuove attività all’estero. Ad esempio costruire fabbriche. Nel 2024 gli investimenti greenfield cinesi nel vecchio continente hanno raggiunto il valore record di 5,9 miliardi di euro, di cui 5,2 miliardi legati alla filiera industriale dei veicoli elettrici, settore nel quale Pechino è il dominatore assoluto a livello mondiale.
Eppure, secondo Merics, il più importante think tank europeo di analisi sulla Cina, anche questo fiorente fronte di sviluppo potrebbe essere destinato ad avere vita breve. Nel corso del 2024 si è assistito infatti a un crollo del 79% dei nuovi progetti cinesi annunciati in Europa, passando da una media di 15 miliardi di euro nel 2022 e nel 2023 a soli 3,1 miliardi di euro.
Svolt Energy – che ha sede a Changzhou, nella provincia di Jiangsu – ha annullato la realizzazione di due impianti di batterie in Germania. Nuode – azienda di Shanghai – ha sospeso la costruzione di una fabbrica di componenti per batterie in Belgio. Il colosso Catl – quartier generale a Ningde, nella provincia del Fujian – sta rivalutando le dimensioni del suo progetto di gigafactory da oltre 7 miliardi di euro che dovrebbe sorgere a Debrecen, in Ungheria.
Dietro questi dietrofront ci sono in prima battuta logiche commerciali, dalla persistente debolezza della domanda europea di auto elettriche (che copre oggi appena il 16,4% delle immatricolazioni) all’elevato costo della manodopera e dell’energia. I cinesi – così come, del resto, le case automobilistiche occidentali – tendono adesso ad andare a produrre in Paesi che offrono condizioni economiche più vantaggiose, in Nord Africa, nell’Europa orientale o anche nella penisola iberica.
Ma a incidere sono anche dinamiche di carattere politico. Merics sottolinea come nell’ultimo anno, forse su pressione del governo di Pechino, i grandi player cinesi abbiano privilegiato, nelle proprie politiche di investimento in Europa, quei Paesi, come Ungheria, Slovacchia e Spagna, che guardacaso si sono opposti o si sono astenuti nel voto sui dazi dell’Ue alle auto elettriche Made in China.
Se gli investitori asiatici scappano è anche perché sentono il fiato sul collo delle istituzioni europee, comunitarie e non. Basti pensare al clamoroso provvedimento con cui lo scorso ottobre il governo olandese ha rilevato il controllo del produttore di chip Nexperia espropriandolo a Wingtech (l’intervento è stato poi sospeso dopo che i cinesi hanno bloccato le esportazioni dei chip dell’azienda). O ancora, circa un anno fa le autorità svedesi hanno bloccato il progetto di Putailai, che prevedeva di produrre anodi in Scandinavia, poiché l’azienda shanghaiese non avrebbe soddisfatto alcune condizioni normative sulla struttura di gestione.
Pro e contro
L’allontanamento dall’Europa dei giganti cinesi può essere letto come una buona notizia nella misura in cui scongiura il rischio operazioni meramente speculative. Un’indagine condotta nel settore automotive dall’autorevole ong belga Transport & Environment ha concluso che gli investimenti provenienti dalla Repubblica Popolare – benché lautamente finanziati dagli Stati locali – non generano trasferimento tecnologico in favore degli europei, poiché la gran parte della componentistica e una quota della forza lavoro vengono attinte da Oriente. Il rischio, in altre parole, è che l’Europa si riduca a diventare una terra di «assemblaggio per gli operatori asiatici che cercano di evitare tensioni geopolitiche e restrizioni commerciali».
Ad esempio, nel land tedesco della Turingia, dove sorge un impianto di batterie di Catl, negli ultimi quattro anni sono improvvisamente schizzate le importazioni di apparecchiature elettriche dalla Cina. Va anche detto, però, che questa dipendenza da forniture estere può essere circoscritta alle fasi iniziali di un’operazione industriale: nella stessa gigafactory Catl in Germania inizialmente i lavoratori cinesi erano la metà del totale, mentre oggi rappresentano meno di un quarto.
D’altro canto – considerato il contesto attuale di predominio di Pechino nella filiera delle auto elettriche – è anche vero che, se nel vecchio continente venisse meno la produzione di batterie cinesi, lo sviluppo dell’industria europea dell’auto elettrica ne risulterebbe ulteriormente rallentato. A meno che i Paesi dell’Ue non riuscissero nella difficile impresa di sviluppare in tempi relativamente brevi una propria filiera autosufficiente.
Due importanti manager del settore metallurgico – l’italo-belga Bart Sap di Umicore e la francese Christel Bories, fino allo scorso maggio alla guida di Eramet – hanno pragmaticamente fatto notare, parlando con il Financial Times, che «l’Europa è rimasta troppo indietro nella tecnologia delle batterie e dovrebbe cercare partnership con gruppi cinesi anziché cercare di costruire un’industria rivale».
Egemonia
Com’è ampiamente noto, l’egemonia cinese non si manifesta solo nel campo delle batterie elettriche. Pechino ha le mani ben salde anche sul 70% dell’estrazione delle sempre più preziose terre rare, necessarie alla fabbricazione di smartphone, computer, lampadine, ma anche droni e altri sofisticati sistemi d’arma. Più del 90% della lavorazione avviene in Cina.
Questa condizione conferisce al Paese guidato da Xi Jinping un potere quasi assoluto sulle catene di approvvigionamento globali. Un potere di manipolazione. A seconda del proprio tornaconto, la Cina può scegliere di inondare il mercato, facendo abbassare i prezzi e mettendo in difficoltà le attività minerarie di nazioni concorrenti come Stati Uniti e Australia, oppure di irretire l’offerta, provocando problematici “colli di bottiglia” nelle forniture e innescando spirali inflazionistiche.
Lo si è visto in maniera chiara negli ultimi due anni, durante i quali il Ministero del Commercio cinese ha introdotto – una dopo l’altra – una serie di paletti all’export di determinate materie prime critiche. Nel 2024 la stretta sull’antimonio (insieme a gallio e germanio) ha costretto il produttore tedesco di adesivi Henkel a invocare la «forza maggiore» per non essere stato in grado di consegnare alcuni prodotti all’industria automobilistica, mentre nei mesi scorsi i limiti introdotti su una lista di sette terre rare hanno spinto alcune associazioni industriali europee a mettere in guardia i consumatori su possibili blocchi della produzione.
Queste restrizioni sono state in parte congelate nell’ambito del recente accordo di tregua sui dazi siglato con gli Stati Uniti di Donald Trump. Ma si tratta solo di una sospensione temporanea: le restrizioni torneranno in vigore a novembre 2026 (salvo proroghe). In questo lasso di tempo, come osserva Antonia Hmaidi, analista senior di Merics, l’Europa ha la possibilità di attrezzarsi per ridurre la propria dipendenza dalle forniture asiatiche. «Non sfruttare la finestra ora aperta per ridurre il rischio nei rapporti economici con la Cina metterebbe a nudo sia la debolezza strategica dell’Europa sia la sua vulnerabilità pratica», scrive Hmaidi. «Non rispondere in modo definitivo agli shock di offerta provenienti dalla Cina danneggerebbe la reputazione dell’Europa come attore globale affidabile, indebolendo ulteriormente il suo peso geopolitico».
Partner e rivale
Sul sito web della Commissione europea, la Cina – terzo partner commerciale dopo Usa e Regno Unito – viene definita «allo stesso tempo un partner, un concorrente e un rivale sistemico».
Negli ultimi anni, l’Ue ha espresso crescenti preoccupazioni riguardo agli «squilibri sistemici» che caratterizzano l’economia cinese. Il riferimento è agli aiuti di Stato al settore manifatturiero che creano sovraccapacità produttiva, ai controlli sulle esportazioni privi di motivazioni chiare e alla spinta da parte del governo di Pechino verso la sostituzione delle importazioni e l’autosufficienza.
«Molte aziende europee – rileva la Commissione – ritengono che il contesto imprenditoriale in Cina sia diventato più politicizzato nel corso degli anni»: «Le sfide economiche sono aumentate, mentre gli ostacoli normativi sono rimasti sostanzialmente invariati, il che ha ulteriormente influito negativamente sulle prospettive aziendali».
Lo ha toccato con mano, ad esempio, Volkswagen, che dopo essere stata tra i primi costruttori europei a sbarcare sul mercato cinese, ricavandone ricchi profitti, nel 2024 ha registrato una flessione a due cifre nel Paese del Dragone, dove ormai sono le aziende di casa a farla da padrone.
A dispetto di quanto si è detto fin qui, ad oggi lo stock degli investimenti europei in Cina è ancora di gran lunga superiore a quello degli interessi cinesi in Europa: 232 miliardi di euro a fronte di 65 miliardi. Tuttavia le aziende occidentali attive in Estremo Oriente iniziano a patire una certa scomodità.
Contromisure
Alla fine del 2020 l’Ue e la Repubblica Popolare hanno raggiunto un accordo sugli investimenti diretti esteri che punta a sostituire i numerosi trattati bilaterali fra le due potenze economiche. L’intesa – che prende il nome di Cai (Comprehensive Agreement on Investment) – è stata però sospesa l’anno successivo sull’onda delle sanzioni europee in materia di diritti umani nei confronti di alcuni funzionari cinesi.
Negli ultimi due anni l’Ue ha cercato di reagire alla crescente dipendenza dalle forniture asiatiche varando alcuni strumenti legislativi mirati a rilanciare la propria industria strategica. Lo European Chips Act, approvato nel 2023, punta a incrementare la produzione europea di semiconduttori – oggi quasi interamente nelle mani di Taiwan e Corea del Sud – fino al 20% del mercato globale entro il 2030. Il Critical Raw Materials Act, entrato in vigore nel 2024, fissa invece ambiziosi obiettivi per garantire forniture sicure di materie prime critiche, promuovendo estrazione, raffinazione e riciclo nell’Unione. Completa il quadro il ResourceEu Act, che dovrebbe promuovere catene del valore locali e sostenibili.
Oggi l’Europa si trova davanti a un bivio strategico: continuare a dipendere dalla Cina rischia di trasformare il vecchio continente in un semplice assemblatore globale, ma forzare l’autosufficienza tecnologica richiede investimenti ingenti e tempo. L’unica strada concretamente percorribile nel medio-breve periodo sembra allora quella di rafforzare la produzione locale, da un lato, e attrarre investimenti con effettivo trasferimento tecnologico, dall’altro. In ballo c’è la sopravvivenza della nostra industria.