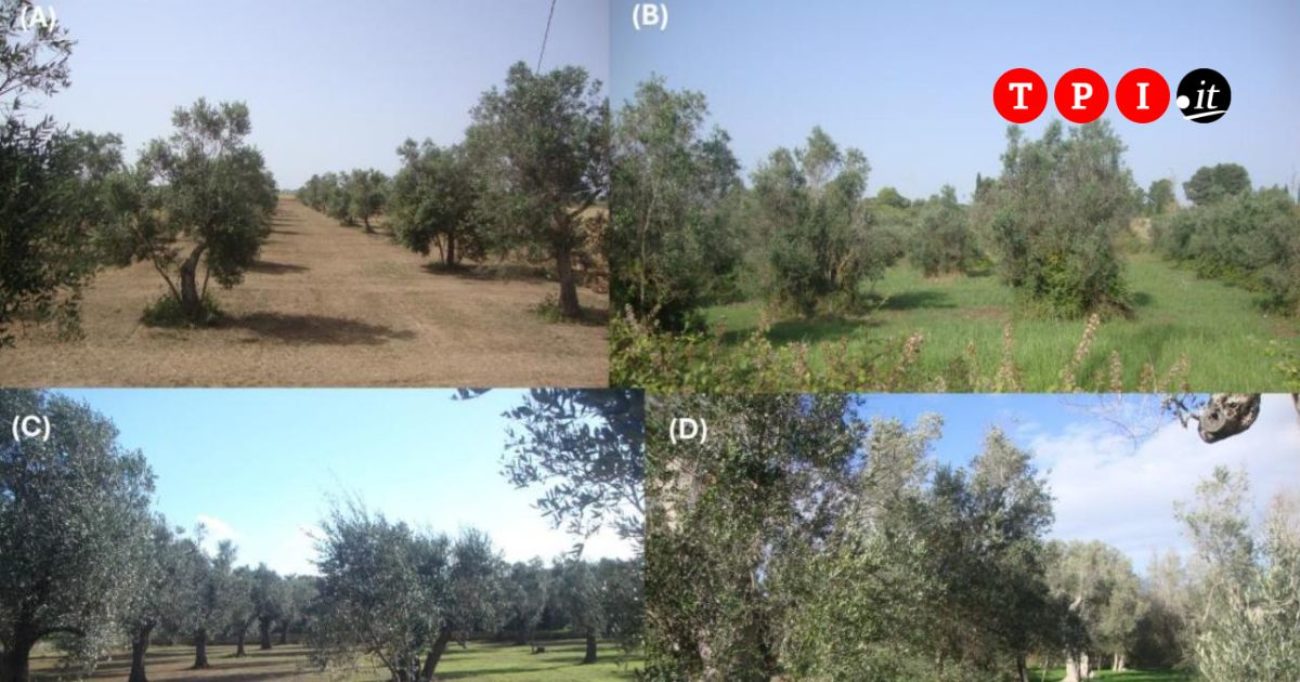Perché Valentina Milluzzo è morta?

Nel 2016 perse la vita a 32 anni dopo oltre due settimane di ricovero all’Ospedale Cannizzaro di Catania. Era incinta al quarto mese di due gemelli. Anche per i feti non ci fu nulla da fare. I medici che la seguirono sono stati condannati in primo grado, poi assolti in appello. Ma i familiari fanno ricorso in Cassazione
Il legale della famiglia di Valentina Milluzzo, l’avvocato Salvatore Catania Milluzzo, ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello di Catania che lo scorso 11 novembre ha assolto quattro medici, condannati in primo grado per omicidio colposo per la morte della giovane donna originaria di Palagonia.
La 32enne, incinta di due gemelli dopo un percorso di procreazione medicalmente assistita, nell’ottobre del 2016 era stata ricoverata all’ospedale Cannizzaro di Catania, al quarto mese di gravidanza, per una dilatazione anticipata del collo dell’utero: le possibilità di un aborto spontaneo erano alte. Dopo diciassette giorni di degenza nel reparto di ginecologia e ostetricia della struttura sanitaria etnea, Valentina Milluzzo morì a causa di una grave infezione all’utero e alle membrane fetali. Con lei anche i due gemelli che portava in grembo e che, come tutti i feti prima delle 24 settimane di gestazione, non avevano alcuna chance di nascere vivi.
Nelle ultime 24 ore di vita la donna aveva la febbre alta, vomitava, faticava a respirare, chiedeva aiuto. I familiari credevano che stesse abortendo, nessuno di loro poteva immaginare cosa sarebbe accaduto poco dopo.
«Sapevamo che la gravidanza avesse poche possibilità di continuare», dichiara in esclusiva a TPI Angela Maria Milluzzo, sorella della vittima. «Ciò che non sapevamo invece, perché non siamo stati mai informati, è che la vita stessa di Valentina era in pericolo perché restare per settimane con il collo dell’utero dilatato e uno dei due sacchi amniotici già sceso in vagina significa esporre una donna alla possibilità elevatissima di ammalarsi di setticemia. Con un aborto terapeutico mia sorella si sarebbe salvata, ma nessuno ce l’ha mai proposto. Noi non sapevamo neanche di essere in un reparto in cui tutti i ginecologi erano obiettori di coscienza, semplicemente ci sentivamo al sicuro perché al primo segnale di rischio abbiamo portato Valentina in ospedale, in una struttura molto nota, di altissimo livello. Eppure non è bastato. Adesso chiediamo giustizia e continuiamo a raccontare cosa è accaduto per evitare che possa succedere ancora ad altre donne».
L’iter giudiziario
Sei anni dopo la morte, nell’ottobre del 2022, è arrivata la sentenza in primo grado con la quale sono stati condannati per concorso in omicidio colposo a sei mesi pena sospesa i quattro ginecologi di turno in reparto negli ultimi due giorni di vita di Valentina Milluzzo. Assolti, invece, il primario del reparto, l’anestesista e il ginecologo che hanno assistito la donna nelle ultimissime ore.
Uno dei punti più controversi della vicenda ha a che fare con un tampone vaginale effettuato sei giorni prima del decesso, che evidenziava un’infezione già in corso. L’esito dell’esame non è mai stato inserito nella cartella clinica, i medici hanno dichiarato che non fosse visibile nell’elenco dei referti ricevuti, ma il documento è stato recapitato alla Procura di Catania dalla direzione sanitaria durante le indagini ed è arrivato, cinque mesi dopo la morte di Valentina, allo studio dell’avvocato della famiglia Milluzzo in forma anonima. Era stato inviato dal laboratorio analisi dell’ospedale al reparto due giorni prima che la donna si aggravasse.
Proprio perché quel tampone che rendeva chiare le condizioni cliniche della paziente era sfuggito ai medici che non lo avevano visto, la giudice Maria Elena Calamita ha emesso la condanna. Valentina Milluzzo, secondo le motivazioni della sentenza di primo grado, con un intervento medico tempestivo e la corretta terapia antibiotica poteva essere salvata.
Questa tesi è stata ribaltata dalla Corte d’Appello di Catania, che nel novembre 2024 ha riformato la sentenza e assolto i quattro ginecologici perché «il fatto non sussiste». Nella sentenza d’appello si legge che non esistono né prove né elementi scientifici solidi in grado di dimostrare che la morte di Valentina Milluzzo sia avvenuta per negligenza e imperizia medica. Secondo i giudici, quindi, la grave infezione che ha colpito la donna non poteva essere diagnosticata né prevista.
La famiglia Milluzzo, insieme al suo legale, continua a chiedere verità e giustizia per Valentina. Per questa ragione l’avvocato Catania Milluzzo ha depositato un ricorso in Cassazione nel quale chiede di annullare la sentenza, al fine solo civile, perché il reato di omicidio colposo è andato in prescrizione il 25 novembre 2024.
«Il giudice d’Appello ha ignorato e travisato la sentenza di primo grado fornendo motivazioni incoerenti e contradditorie che non possiamo accettare e che contestiamo apertamente», dichiara a TPI l’avvocato Salvatore Catania Milluzzo. Nelle motivazioni indirizzate alla Cassazione si legge che il processo in appello «iniziava sotto infausti auspici» perché il giudice relatore designato voleva astenersi «per pregressa conoscenza» con il primario del reparto, ma la richiesta non è stata accolta dal primo presidente della Corte.
Era obbligo dei medici che hanno avuto in cura Valentina Milluzzo non solo conservare la gravidanza, ma prevenire il rischio di infezioni, che in questa situazione era elevatissimo, scrive il legale nelle oltre sessanta pagine consegnate in Cassazione.
Quasi al termine del processo in appello, la Corte ha richiesto una perizia informatica sui server dell’ospedale Cannizzaro per capire se si fosse verificato qualche guasto che non rendeva fruibile l’esito del tampone vaginale ai medici. L’esame sul sistema ha evidenziato che il referto era disponibile già due giorni prima che le condizioni di Valentina Milluzzo precipitassero, proprio quando è stato inviato dal laboratorio analisi, ma parrebbe che non fosse mai stato aperto e visionato da nessuno dei ginecologi di turno.
L’ultima parola sul caso Milluzzo passa alla Corte di Cassazione che, in seguito al ricorso presentato dal legale della famiglia, ai soli fini di responsabilità civile, si pronuncerà con una sentenza attesa per il prossimo 11 novembre, a un anno esatto dall’assoluzione in Appello.
Obiezioni di coscienza
Il tema dell’obiezione di coscienza di tutti i ginecologi del reparto non è mai entrato di fatto nella vicenda processuale del caso Milluzzo perché a pochi giorni dalla morte della donna il Ministero della Salute ha effettuato un’ispezione che ha escluso la connessione tra il decesso e la presenza di soli ginecologi obiettori.
Eppure la questione in Italia resta aperta. L’Istituto superiore di sanità ha fornito il primo elenco ufficiale delle strutture pubbliche e convenzionate, ospedali, cliniche, consultori (i dati sono del 2023) che effettuano aborti volontari e terapeutici. Manca però il tasso di obiettori di coscienza per ogni singola struttura. La legge 194/78 prevede che ogni ospedale abbia personale in grado di garantire l’interruzione di gravidanza, ma in pratica questo non accade perché la percentuale di ginecologi obiettori nel nostro Paese è altissima e sono tanti i reparti in cui ancora si verifica la cosiddetta «obiezione di struttura».
Abortire in Italia non è affatto semplice, ma non lo è neanche partorire senza subire abusi, il che ha acceso i riflettori negli anni anche sul tema dell’autodeterminazione femminile, dei diritti riproduttivi e sul fenomeno della violenza ostetrica e ginecologica.
I risultati preliminari di uno studio dell’Università di Urbino Carlo Bo, condotto dalla professoressa Lucia Ponti, dicono che oltre il 76% delle donne in gravidanza, durante il parto o il post parto hanno subito trattamenti irrispettosi e violenti dal punto di vista fisico, verbale e psicologico. Non si fa riferimento a situazioni emergenziali, ma di routine, durante le quali le donne non sono ascoltate, comprese e ricevono cure standardizzate, spesso imposte, senza informazioni adeguate, chiare e accessibili.
Da aprile il Portogallo è il primo Paese europeo con una legge che introduce il concetto di violenza ostetrica, definita come «qualsiasi atto o omissione da parte di un professionista sanitario, che nel contesto della salute sessuale e riproduttiva, provochi danni fisici, o psicologici, limiti l’autonomia decisionale o implichi trattamenti disumanizzanti e degradanti». La legge parla anche dell’uso eccessivo di interventi medici senza motivazione clinica e senza consenso esplicito. L’obiettivo è garantire un’assistenza fondata proprio sul consenso informato, per difendere l’integrità psicofisica ed emotiva di chi diventa madre. Tutti i punti nascita del Paese, pubblici e privati, saranno inoltre obbligati ad esporre dei cartelli informativi visibili con i diritti delle partorienti e le modalità per segnalare eventuali abusi.