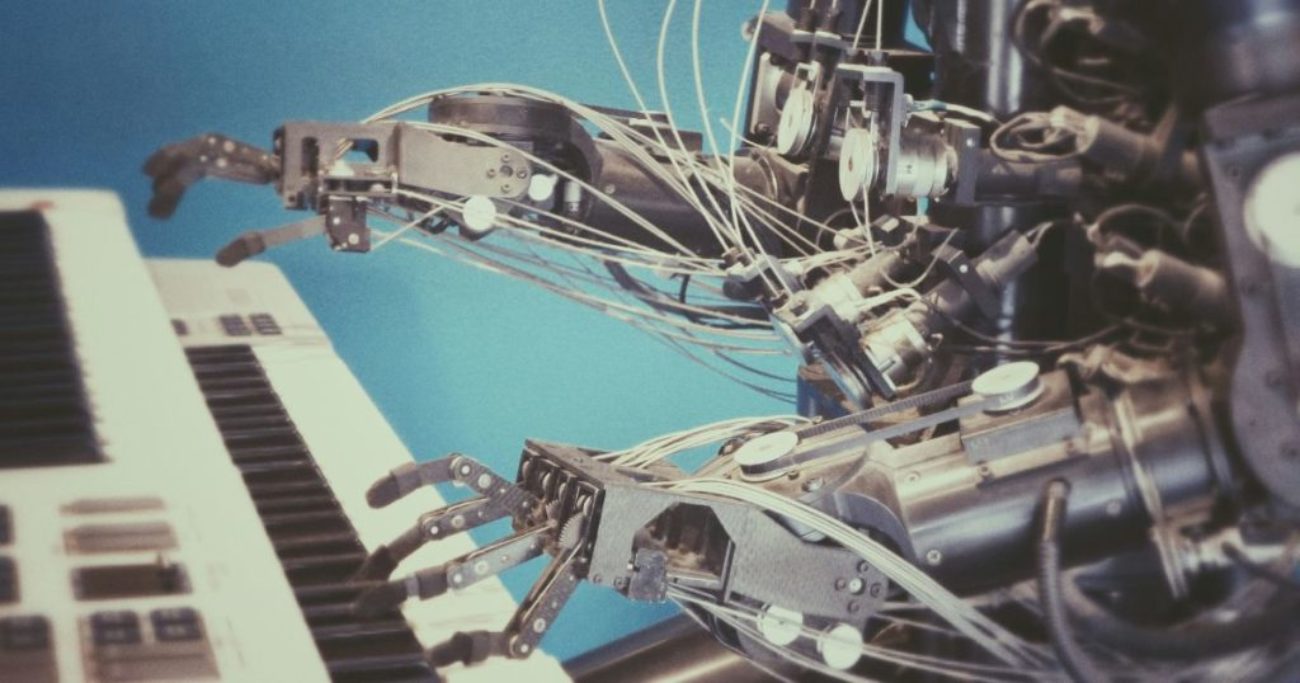Il mondo è in fiamme: siamo entrati in un nuovo ordine globale

Le mosse a sorpresa di Trump, le difficoltà del regime di Teheran, le manovre dietro le quinte di Netanyahu. Dal Venezuela alla Groenlandia. Dall’Iran all’Ucraina. Passando per Gaza, Cuba, Taiwan, Yemen e il Somaliland. Come orientarsi nei focolai che infuocano il pianeta
Che l’ordine globale sia in subbuglio è un’affermazione che viene riproposta da tempo, e le conferme non mancano. Anzi, esse si sono ripresentate con particolare forza proprio all’apertura di questo 2026. Mentre in Ucraina la guerra non si ferma e a Gaza la tregua rimane fragile e costellata da punti interrogativi, in Iran è esplosa un’ondata di proteste divenuta rapidamente uno scontro sempre più aperto, al quale il regime degli ayatollah ha risposto con una sanguinosa repressione. In Venezuela, gli Stati Uniti hanno compiuto una mossa clamorosa: la cattura del presidente Nicolás Maduro. Israele, intanto, ha riconosciuto la Repubblica del Somaliland, mettendo in moto un risiko che ha coinvolto molti Paesi della regione. Così da Taiwan alla Groenlandia, da Cuba allo Yemen, tutti i punti caldi del pianeta sono diventati osservati speciali in una situazione tesa che può incendiarsi con grande facilità.
Il blitz anti-Maduro
Facciamo un passo indietro. Andiamo allo scorso 25 dicembre, giorno di Natale. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sceglie deliberatamente questa data per dare seguito alla minaccia di colpire i gruppi terroristi nigeriani responsabili dell’uccisione di cristiani nel Paese, ordinando bombardamenti contro alcune postazioni dei miliziani della ramificazione locale dello Stato Islamico. Secondo alcuni articoli usciti sui media d’Oltreoceano, quel giorno era stato originariamente scelto per un intervento in Venezuela, che per evitare la sovrapposizione è slittato ai giorni successivi, anche a causa di condizioni meteorologiche non ottimali.
Si arriva così al 3 gennaio 2026, sei anni esatti dopo un’altra clamorosa operazione a firma Trump, l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani all’aeroporto di Baghdad. Proprio nel cuore della notte tra il 2 e il 3 gennaio, le forze speciali statunitensi hanno colpito alcune basi e obiettivi strategici in Venezuela e, nella capitale Caracas, hanno effettuato un’azione militare che ha portato alla cattura del presidente Maduro e della moglie Cilia Flores in un’operazione che non ha precedenti e che, anche per questo, ha suscitato molte preoccupazioni sul piano del diritto internazionale.
Se tante volte nel Novecento abbiamo assistito a golpe, guerre civili o decimazione dei vertici, se il dispiegamento di truppe americane nei Caraibi aveva lasciato un punto interrogativo su che tipo di azione Washington avrebbe compiuto, alla fine quella messa in campo ha sorpreso tutti e mandato il suo messaggio al mondo: cattura mirata del capo di stato, portato a New York e lì processato non da un tribunale internazionale, né come prigioniero di guerra o leader sconfitto, ma in una corte distrettuale in mezzo a tanti criminali comuni. Questo, mentre tutto il governo venezuelano di stampo chávista restava al proprio posto, con la vice di Maduro, Delcy Rodríguez, che assumeva la guida del Paese, ma con Trump che spiegava loro che avrebbero fatto bene da quel momento a seguire le indicazioni americane.
La situazione è per definizione fluida, tanto più che il governo di Maduro aveva perso da tempo il riconoscimento di molte nazioni, ma ad oggi ci troviamo di fronte a un regime che non è cambiato, ma con la forza è stato indirizzato verso gli Stati Uniti.
Il biglietto da visita con cui l’America targata Trump ha aperto il 2026 sembra essere esattamente questo. È finita l’epoca del dialogo, dei tavoli di confronto, delle lunghe trattative per gli accordi multilaterali, in un mondo in cui il diritto internazionale è andato via via sgretolandosi e in cui le istituzioni globali appaiono sempre di più espressioni di un vecchio ordine che non esiste più, mentre è iniziata la stagione della legge del più forte, in cui Trump detta le sue condizioni ed è pronto a usare la forza, sia essa a colpi di bombe o di dazi, per prendersele.
America e Americhe
Così, dopo il Venezuela, l’attenzione del mondo si è spostata verso quegli angoli delle Americhe che Trump aveva in un modo o nell’altro menzionato tra le più o meno velate rivendicazioni geopolitiche americane.
C’è il canale di Panama, che, appena eletto presidente, il tycoon aveva affermato di voler riportare sotto la sovranità americana, lamentando gli elevati tassi richiesti alle imbarcazioni statunitensi e denunciando il rischio che un passaggio così strategico e costruito proprio dagli States si allineasse a potenze concorrenti.
C’è la Colombia, guidata dal presidente Gustavo Petro, con cui Trump non ha mai avuto un rapporto idilliaco (è stato dichiarato «persona non grata» negli Stati Uniti dopo aver invitato le forze dell’ordine americane a disobbedire a Trump) e contro cui la Casa Bianca ha puntato il dito per il ruolo del Paese nel narcotraffico.
C’è Cuba, unico Stato comunista delle Americhe per gran parte della guerra fredda, ormai guidata da un presidente nato dopo la rivoluzione di Fidel Castro, cui Trump ha dichiarato che non dovranno arrivare più petrolio né soldi da Caracas.
E poi, soprattutto, c’è la Groenlandia. Ed è qui, che oggi, si focalizzano gran parte delle attenzioni.
L’isola contesa
Questa isola immensa ma scarsamente popolata, geograficamente strategica e ricca di terre rare, fa parte del Regno di Danimarca e di conseguenza è membro della Nato. Ospita un’importante base americana, Pituffik, dal 1951 con un trattato che offre a Washington ampi diritti operativi per i suoi militari. Nonostante questo, Trump non ha mai nascosto la sua convinzione che il controllo strategico della Groenlandia sia essenziale per la difesa nazionale degli Stati Uniti, insistendo pubblicamente sulla necessità americana di controllare l’isola per motivi di sicurezza artica e per il suo valore strategico contro l’influenza di Cina e Russia.
Subito dopo l’operazione in Venezuela, il presidente degli Usa ha rilanciato queste richieste, spingendo nuovamente per una forma di controllo sulla Groenlandia. Le tensioni che ne sono scaturite hanno portato numerosi Paesi europei, tra cui Francia e Germania, a inviare contingenti sull’isola come dimostrazione di sostegno alla sovranità di Copenaghen. Risposta di Trump? Dazi alla Danimarca e a coloro che hanno mandato i propri soldati, per far capire che non si tratta di una boutade di inizio anno, per quanto nella totale imprevedibilità trumpiana non è assolutamente chiaro che strada prenderà questa storia.
Ayatollah in crisi
Ma le Americhe non costituiscono l’unico orizzonte della Casa Bianca, nonostante in molti avessero ipotizzato che il «Make America Great Again» trumpiano lo avrebbe relegato a una nuova versione della dottrina Monroe, focalizzata sull’egemonia nel proprio continente. E infatti, proprio nei giorni in cui maturava l’operazione venezuelana, in un’altra parte di mondo, in Iran, iniziavano una serie di proteste contro il carovita che ben presto hanno mostrato al mondo caratteristiche ben diverse dalle cicliche ondate di manifestazioni che attraversano il Paese.
In breve, in tutto il territorio della Repubblica islamica si sono verificati scontri sempre più violenti, accompagnati da una crescente repressione da parte del regime che l’8 gennaio ha bloccato internet e gran parte delle comunicazioni in tutto il Paese. Questo blackout nel momento in cui scriviamo è ancora in vigore, rendendo ancora più difficile far capire al mondo cosa stia accadendo. Tra le poche notizie filtrate attraverso la coltre imposta dagli ayatollah, emerge con chiarezza un dato drammatico e preoccupante: il regime ha risposto alle proteste con una repressione sanguinosa.
È ben noto quanto i numeri che arrivano da un teatro bellico siano pressoché inverificabili, ma gli elementi disponibili indicano una situazione particolarmente grave.
Questa protesta, tuttavia, non è iniziata in un momento qualsiasi: lo scorso giugno Israele ha colpito duramente l’Iran nella guerra dei dodici giorni, impartendo una dura ferita alle sue difese, alla sua leadership e al programma balistico e nucleare che, il 22 giugno, ha subito un colpo decisivo dai bombardieri statunitensi sui reattori iraniani che ha posto fine al conflitto.
Mentre il regime degli ayatollah mostrava tutta la sua vulnerabilità, non sembrava però voler mettere da parte il suo programma, così come Israele, dal canto suo, non sembra ancora voler concludere l’ampio conflitto su più fronti iniziato dopo il 7 ottobre che lo vede contrapposto alle varie ramificazioni dell’Iran in tutto il Medio Oriente.
Proprio mentre a Teheran la gente iniziava a scendere in piazza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si trovava da Trump a Mar-a-Lago, in Florida, parlando tra le altre cose di un secondo round contro l’Iran di cui si vocifera da mesi. Proprio le proteste e la carneficina messa in campo dagli ayatollah hanno permesso al leader degli Stati Uniti di dire chiaramente agli ayatollah che, se avessero ucciso i manifestanti o avesse eseguito condanne a morte sarebbe arrivata una risposta molto dura.
Oggi il regime sembra nella sua peggiore condizione di salute dalla rivoluzione khomeinista a oggi, come lasciato intendere dal cancelliere tedesco Friedrich Merz secondo cui un regime che uccide i suoi giovani è alle battute finali. Ma la questione non è certo così semplice: da un lato la destabilizzazione dell’Iran, senza una leadership alternativa chiaramente condivisa, rischia di trasformarsi in una polveriera, mentre dall’altra non è detto che Russia e Cina, storicamente vicine a Teheran, accettino la cosa di buon grado, soprattutto dopo la caduta di Maduro, con le pressioni di Pechino su Taiwan e la Russia che non sembra voler arretrare dai suoi obiettivi in Ucraina nemmeno dopo quasi quattro anni di guerra.
Non sappiamo, dunque, se questa attesa di un attacco americano che ancora non è arrivato sia per una questione di prudenza o perché i preparativi sono ancora in corso, così come non sappiamo quali sarebbero gli obiettivi di un attacco, per arrivare a quali risultati, o se alla fine si preferirà desistere.
Ad oggi attrezzature belliche americane continuano a raggiungere le basi del Medio Oriente, ma Trump ci ha insegnato che con lui c’è davvero da aspettarsi di tutto.
Intanto nel Corno d’Africa…
Intanto, nel Corno d’Africa è successa una cosa all’apparenza marginale in tutto questo marasma: Israele ha riconosciuto ufficialmente il Somaliland, repubblica di fatto indipendente che la comunità internazionale riconosce come parte della Somalia. Ovviamente una decisione del genere non arriva di punto in bianco: i rapporti tra il governo israeliano e quello della piccola repubblica sono strutturati da tempo, tanto che di questo territorio si era parlato come possibile meta per i palestinesi in fuga dalla devastazione di Gaza.
La domanda da farsi in questi casi, però, è come mai il riconoscimento è arrivato proprio adesso. Negli ultimi mesi, infatti, è venuta meno la principale arma di pressione per scoraggiare Israele da questa decisione, ovvero minacciare di riconoscere uno Stato palestinese, dal momento che con la guerra di Gaza quasi tutti i Paesi disposti a compiere questo gesto lo hanno fatto. Israele, dal canto suo, mostra di essere proattivo a livello diplomatico, approfondendo i suoi rapporti con gli Emirati Arabi Uniti (forse il massimo successo degli accordi di Abramo), principale alleato del Somaliland, e trovando così un nuovo alleato nel Corno d’Africa, proprio di fronte a quel passaggio d’acqua, lo stretto di Bab el-Mandeb, che fa d’accesso al Mar Rosso, e proprio su quel Golfo di Aden dove si affaccia lo Yemen, dove sono attivi gli Houthi, tra i massimi alleati dell’Iran nella regione. Ma anche colpendo così la Somalia, uno dei più stretti alleati della Turchia nella regione, i cui rapporti con lo Stato ebraico sono oggi pessimi, e mettendo un piede in quel Corno d’Africa dove si intrecciano tanti interessi che portano anche verso la Cina, non certo felice di trovare un attore in più nella regione.
E quindi, questo piccolo pezzo di Corno d’Africa, che fino a oggi raramente ha trovato spazio nelle pagine dei giornali, diventa un crocevia da cui passano lo scontro tra Israele e Iran, i rapporti di forza del Medio Oriente e persino quelli tra Occidente e Cina. Questo mentre molti Paesi sembrano ritenere che una politica estera aggressiva sia la miglior forma di tutela in un momento in cui l’ordine globale e il diritto internazionale sembrano divenuti inconsistenti. Se questo sia parte di un riallineamento degli equilibri, lo vedremo, sperando vivamente non siano i preparativi di scontri più ampi: la palla è ora in mano alle grandi potenze, Trump in primis, e per come abbiamo imparato a conoscerlo, l’imprevedibilità è forse la caratteristica che meglio lo rappresenta.