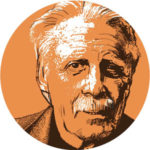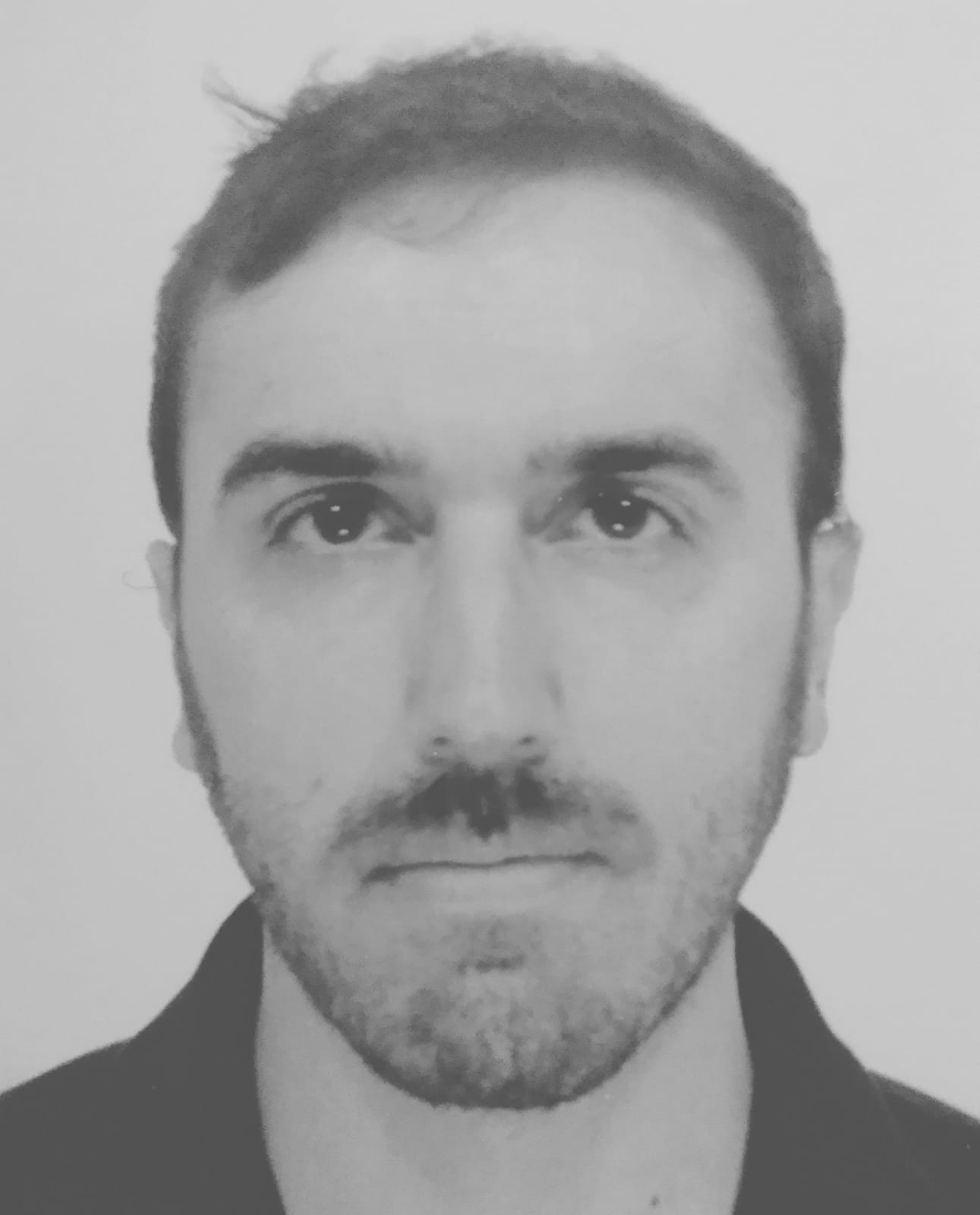“Solo il Mediterraneo può salvare questa Europa”

“A differenza di Usa e Cina l’Europa è senza gas, petrolio e terre rare. Dipendiamo dalle forniture estere. E questo ci rende deboli. Dovremmo puntare sulla nostra posizione centrale nelle nuove rotte commerciali tra Africa e Oriente. Ma finché l’Ue non parlerà con una voce sola sarà condannata all’irrilevanza”. Colloquio col professor Albanese Ginammi, docente di Economia Politica all’Università per stranieri di Perugia
Professore, cominciamo tastando il polso all’economia europea. Da un lato, abbiamo un rallentamento dell’inflazione, la stretta monetaria e il ritorno del Patto di Stabilità. Dall’altro la corsa al riarmo e la transizione ecologica e digitale. Facciamo un bilancio: come sta oggi il Vecchio Continente?
«Il commissario Paolo Gentiloni (commissario europeo agli Affari economici, ndr) di recente ha presentato un quadro cautamente ottimista, almeno nel breve termine. Nei prossimi mesi si prevede un’accelerazione dell’attività economica, con una crescita dei consumi privati e una sempre più probabile diminuzione dell’inflazione. Ma tutto ciò avviene in un contesto di fortissima incertezza, che è determinato dalla situazione geopolitica globale. E se guardiamo ai dati dell’occupazione – che sono più significativi per dirci come sta davvero l’economia reale – vediamo che il confronto con gli Stati Uniti negli ultimi tre o quattro anni è impietoso. L’occupazione in America va meglio rispetto all’Europa. Per sintetizzare, direi che le parole chiave oggi sono incertezza e debolezza».
In cosa la “Bideneconomics” si è rivelata più efficace rispetto alle politiche della Commissione europea?
«Anche negli Usa, con la pandemia di Covid-19, si è innescata una crisi senza precedenti che ha bloccato domanda e offerta, ma il governo di Washington ha reagito distribuendo aiuti direttamente ai lavoratori, anziché alle imprese come ha fatto invece l’Ue. Questa si è rivelata una scelta strategica migliore, perché ha dato sicurezza ai lavoratori, proteggendo i loro risparmi personali. L’Europa invece ha scelto di aiutare le imprese: così però il destino dei lavoratori è stato lasciato in balia delle scelte dei loro datori di lavoro. Ne è risultato che il mercato del lavoro europeo è stato più depresso di quello americano».
I problemi dell’Unione europea derivano anche dalle regole che la governano?
«Non c’è dubbio. I problemi derivati dai Trattati europei non sono stati risolti e le politiche di austerity adottate nei momenti di crisi non hanno pagato. Il Trattato di Maastricht ha parametri impossibili da rispettare per molti Paesi e questo ha finito per minare la credibilità del progetto europeo. A voler lanciare una sorta di provocazione, potremmo dire che gli Stati Uniti sono stati più keynesiani dell’Europa, avendo speso in questi anni molti più soldi. Inoltre, se l’Ue zoppica è anche per il mancato completamento dell’unione sotto i profili fiscale, politico e militare. Questo è un enorme problema, in un contesto globale in cui gli altri attori invece corrono e anche velocemente».
L’invasione russa dell’Ucraina ha svelato una delle più importanti fragilità dell’economia Ue: la non autosufficienza energetica. Al contempo, nel percorso verso una rivoluzione ecologica, noi europei dobbiamo fare i conti con la scarsità di materie prime strategiche. L’Unione è condannata a dipendere dalle forniture estere?
«A questo proposito recupero una citazione del professor Vittorio Emanuele Parsi (docente di Relazioni Internazionali alla Cattolica, ndr) che ha fatto notare di recente come l’Europa per lungo tempo abbia vissuto in un sogno: quello di vivere in una condizione privilegiata per cui era protetta militarmente dagli Stati Uniti e al contempo poteva accedere alle vantaggiose forniture energetiche russe e alle merci a basso costo cinesi. Con la guerra in Ucraina, è come se l’Europa si fosse improvvisamente svegliata da questo sogno. A ciò si aggiunge la transizione ecologica, che sta cambiando l’industria estrattiva. In questo contesto, l’Ue è stretta in una morsa: se Cina, Stati Uniti, Russia, America Latina, India e Sud-est asiatico portano avanti le nuove attività estrattive delle materie rare e al contempo però continuano la ricerca di fonti energetiche non rinnovabili, allora quello che fa l’Europa conta poco. L’Ue può forse aspirare a diventare un piccolo modello di tutela ecologica dell’ambiente».
La Commissione europea, peraltro, sta incentivando l’esplorazione alla ricerca di materie prime strategiche sul territorio dell’Ue. Può bastare a renderci, in futuro, un continente potenzialmente autonomo?
«Anche se questa ricerca avesse grande successo, l’impatto sarebbe comunque relativo, non in grado di rendere l’Europa autosufficiente. Anche perché siamo un continente molto popolato con grandi esigenze dal punto di vista del mercato. La dipendenza dall’esterno continuerà a esporci alla solita posizione di fragilità. Fra l’altro noi abbiamo leggi molto ferree in materia di apertura di nuove miniere e di ricerche nel sottosuolo… Ma, anche ammettendo che dal punto di vista regolatorio e legislativo le maglie vengano allargate, la quantità di giacimenti presenti in Europa è poca cosa, se confrontata con altre regioni del mondo».
Cinicamente, ci converrebbe muoverci come la Cina, stringendo accordi ad esempio in Africa per sfruttare loro i giacimenti?
«Dal punto di vista economico forse sì, magari con dei nuovi modelli di cooperazione. Ma occorrerebbe che l’Europa parlasse con una voce sola. E allo stato attuale lo vedo improbabile. Ricordiamoci poi che nei Paesi africani la trappola del debito cinese ha creato effetti non molto diversi rispetto a quelli del vecchio approccio colonialista-imperialista occidentale».
Le filiere si stanno accorciando, molte delle produzioni che erano state delocalizzate in Asia stanno tornando in Europa. Significa che la globalizzazione è finita?
«Finita no, ma sicuramente siamo a un punto di svolta. Si cerca di accorciare le filiere per avere costi inferiori rispetto alle grandi rotte commerciali che sono minacciate dall’incertezza geopolitica globale. Questo è un tema particolarmente interessante per l’Italia. In questa ridefinizione della globalizzazione, infatti, il Mediterraneo assume un ruolo di centrale importanza, con nuovi luoghi di transito di merci che portano sviluppo economico e industrializzazione: il Mezzogiorno italiano, per la sua posizione geografica, potrebbe inserirsi appieno in questo processo. Le nuove rotte tra Europa, Africa, Balcani, Medio Oriente potrebbero rappresentare un’occasione di rilancio per il nostro Sud e per tutta l’Europa del Sud. Però, anche qui, vale ciò che ho detto prima: perché ciò accada, bisognerebbe avere la forza, come Ue, di parlare con una sola voce. E oggi purtroppo questo non si vede».
Per molto tempo in Europa chi parlava di politica industriale veniva accusato di essere un pericoloso dirigista. A partire dalla pandemia, invece, nell’Ue si sta riscoprendo l’importanza dell’intervento pubblico in economia. Dobbiamo dedurne che il libero mercato ha fallito?
«Dire che ha fallito è eccessivo, ma sicuramente è in crisi. Oggi il credo liberista del “piccolo Stato” che sta a guardare è messo in crisi come fu durante la grande depressione del 1929. Ci ritroviamo in un altro di quei cicli storici in cui l’economia classica viene messa in discussione da una forte contrazione dell’economia. Il fatto è che il libero mercato non è in grado di affrontare i costi sociali di una grande crisi e quindi è costretto a chiedere aiuto allo Stato. Lo abbiamo visto, appunto, con la pandemia, quando anche i neoliberisti e gli anti-statalisti più accaniti hanno invocato l’intervento pubblico. Al netto di tutto questo, peraltro, la grande stagione delle privatizzazioni e delle de-regolamentazioni non è mai finita: va avanti e ha superato indenne la recessione del 2008 e tutte le crisi successive. C’è insomma una grande schizofrenia nelle teorie che dovrebbero ispirare le politiche economiche degli Stati. Quanto all’Europa, mi duole osservare che l’Ue non potrà mai avere una propria politica industriale finché non avrà un proprio governo politico. Anche per questo servirebbe una riforma dei Trattati».
I nostri alleati statunitensi vedrebbero logicamente come fumo negli occhi un riavvicinamento tra l’Ue e il Cremlino. Ma, dal punto di vista strettamente economico, a noi europei conviene chiudere le porte agli scambi con la Russia a tempo indeterminato?
«Ragionando sul piano della irrealtà, è evidente che ci farebbe comodo avere accesso al gas russo, ma bisogna considerare che Mosca è un partner imprevedibile. Non sappiamo quali sarebbero le conseguenze: in altri termini, non sappiamo cosa il Cremlino ci chiederebbe in cambio. Quel che è certo è che l’Europa oggi ha uno scarsissimo spazio di autonomia rispetto agli Stati Uniti e vedo quindi altamente improbabile un riavvicinamento con la Federazione russa».
In questo nuovo disordine globale sempre più multipolare, quale ruolo può o dovrebbe giocare l’Unione europea?
«Nella grande speranza di un’accelerazione sulla riforma dei Trattati europei, le questioni strategicamente più importanti che noto sono due. La prima l’ho già accennata sopra: rilanciare il Mediterraneo da un punto di vista commerciale e sociale, ribaltando anche la questione delle migrazioni a proprio vantaggio per ripopolare il nostro continente. Penso anche al discorso delle filiere: dovremmo puntare molto su accordi con i Paesi dell’Africa e del Medio Oriente, ma anche col Caucaso e oltre verso l’Asia. Paradossalmente, in una visione forse troppo ottimistica, potremmo pensare anche a riallacciare i rapporti con la Russia, perché Putin non è eterno…».
E la seconda questione?
«Dovremmo cercare di potenziare l’export e insieme attirare più investimenti. L’Europa è già un polo di grande attrazione per il turismo: i cittadini di Stati Uniti, Cina, India e in generale di tutti i Paesi del mondo continuano ad avere una grande passione per l’Europa, per le città europee, per la storia e per l’arte, per le spiagge del Mediterraneo, eccetera… Dovremmo però dotarci di una politica che sia in grado di catalizzare non solo turisti ma anche investimenti, in modo da capitalizzare appieno la nostra grande attrattività e rilanciare una vera politica industriale e commerciale che faccia dei prodotti europei un’eccellenza mondiale. Questo potrebbe compensare in qualche modo la nostra attuale posizione di fragilità».